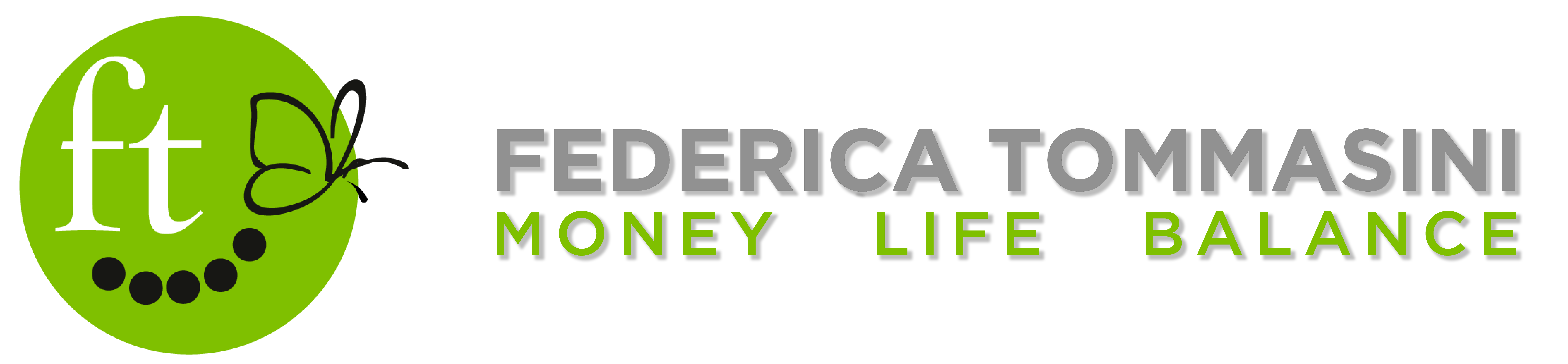IL GRAN MARE DEI SARGASSI
Che vita è quella in cui i soldi sono il fine e non un mezzo?
Introduzione
“Il Gran mar dei Sargassi” è un romanzo postcoloniale e postmodernista di Jean Rhys, pseudonimo di Ella Gwendolen Rees Williams (Roseau, 24 agosto 1890 – Exeter, 14 maggio 1979), scrittrice britannica di origini caraibiche, pubblicato nel 1966. E’ il suo ultimo romanzo, quello che ebbe il successo che ella meritava. Fino a quel momento visse infatti una vita travagliata, in povertà e con dipendenza da alcol.
“Ho sempre scritto solo di me stessa” racconta la Rhys quando verrà insignita in età avanzata dell’onorificenza dell’Eccellentissimo Ordine dell’impero Britannico. Nata in Dominica da padre gallese e madre creola, cresce in una grande proprietà negli anni in cui la schiavitù è appena stata abolita. Leggendo la sua biografia si comprende bene come molti aspetti siano in comune con la vita di Antoinette Cosway Mason, la protagonista del romanzo.
Prequel di “Jane Eyre” di Charlotte Bronte (del 1847), descrive infatti le circostanze e le dinamiche del primo matrimonio del Signor Rochester, nome che non viene mai citato dall’autrice ma che echeggia per tutto il romanzo se solo si conosce il “Jane Eyre”.
La scelta, geniale, di raccontare la storia della demoniaca “mad woman in the attic” palesa la capacità empatica, la sensibilità e la profonda conoscenza che la Rhys possiede e che la fecero esser portavoce, nei suoi scritti, degli umili, dei fragili. Siamo di fronte a un grande romanzo di partnership che sottolinea la necessità di amore, fraternità, comprensione e dialogo tra le parti e le persone per poter sviluppare una società diversa, dove cura, attenzione e collaborazione siano le vere protagoniste, come ci spiega la Eisler con la Teoria della trasformazione culturale.
Il grande mare che divide la Giamaica e l’Inghilterra potrebbe quindi diventare un territorio di incontro, di unione e di realtà sostenibile invece che permanere come spazio di conflitto, distanza e sogno.
Nel romanzo è anche magicamente descritto come la natura sia a supporto della vita (Il nostro giardino era grande e bello..vi cresceva l’albero della vita) e di come il femminino sia naturalmente più portato a un rapporto profondo e innato con essa.
Sottolineo qui anche come l’aspetto mutuale sia rintracciabile anche nella struttura del romanzo stesso per due motivi:
- come già anticipato si pone in relazione, senza rinnegare nulla, ad un altro grande romanzo
- è un raccontarsi a più voci: si ascolta e conosce la storia da tre punti di vista (Antoinette,
Rochester e Grace Pool) anche se racconta nello specifico del dramma esistenziale della prima. Sarebbero logicamente tantissimi gli aspetti che potrebbero essere sviluppati quindi scelgo di approfondirne tre: le conseguenze psicologiche date da una cultura di dominio, il tema del conflitto interpersonale e di genere e il rapporto con il denaro dei protagonisti, aspetti che si incontrano sempre nelle tre parti del romanzo.
Le conseguenze psicologiche date da una cultura di dominio
Interamente dedicata all’infanzia di Antoinette, una bambina che non riesce a trovare un modello di riferimento, che cresce senza una comunità che la ospiti e la protegga. Non è bianca, non è negra e non è la figlia preferita. Una madre bambina che non riesce a superare i suoi disagi e che non può dare l’amore e la cura necessari a uno sviluppo sereno ed equilibrato di Antoinette, che cresce con la paura (dorme con un bastone accanto al letto).
Ha la grande fortuna di incontrare Christophine che la accudisce e che diventerà il suo punto di riferimento. Non è la madre e in più è di colore e pratica lo Obeah ma è donna di carattere, senza marito, indipendente economicamente, onesta e coerente, senza paura dell’uomo bianco.
Da bimba Antoinette ha molta libertà ed è spesso sola; la sua stessa migliora amica, Tia, la rinnega e lo farà per tre monete che portano le bambine a una guerra tra chi è la più povera… e a separarsi come compagne di giochi. Non è una bianca, non è ricca e non è una negra: è una blatta bianca. Angoscia e disperazione potrebbero arrivare ed infatti vivrà sempre sentendosi diversa, estranea e umiliata (tu vai via blatta bianca…). Mai veramente in grado di dare una risposta alla domanda: Chi sono? Ma c’è una cosa che la salva: la Natura intorno a lei a Coulibri, con cui sviluppa una fortissima relazione simbiotica.
Lei sente la madre terra e vive esperienze di contatto spirituali con il proprio Sé (Guardando senza pensare a nulla i fiori rossi e gialli sotto il sole era come se si aprisse una porta e io fossi altrove, qualcos’altro. Non più io): il suo istinto selvaggio e la natura la aiutano a sopravvivere.
Abolita la schiavitù, la famiglia di Antoinette vive una profonda crisi: il padre Cosway, autoritario e prevaricatore muore alcolizzato, la madre Annette, disperata per le avverse condizioni economiche si risposa con Mason, un ricco colone inglese, ma è impaurita dalla minaccia della popolazione di colore che ora è apertamente “contro” di loro. Il conflitto di genere si consuma qui con un marito che non è in grado di fidarsi e ascoltare veramente i timori della moglie, dichiarandoli illusorie sciocchezze. Così la tragedia annunciata avviene: Coulibri viene bruciata, Pierre muore e Tia ancora una volta rinnega l’amica. La madre sprofonda nella pazzia e nessuno farà nulla per aiutarla, anzi.
Grazie a zia Cora e a un affetto formale di Mr. Mason, Antoinette entra in collegio e viene poi promessa in sposa a un gentiluomo inglese che capiremo esser poi Mr. Rochester.
Zia Cora è una figura importante: saggia e protettiva verso la nipote, capace e indipendente. Interessante sottolineare che questo stato le arriva dalla vedovanza che le procura libertà anche finanziaria. Ma Antoinette non ascolterà la zia e cederà alle lusinghe del futuro sposo e lo fa per il suo profondissimo bisogno di amore e di appartenenza, ciò che desidera e teme al contempo.
Conflitto interpersonale e di genere
Parlano prima lui e poi lei: è l’inizio del loro matrimonio e della luna di miele a Granbois, su cui la famiglia Mason ha una proprietà. Capiamo che sposandosi Antoinette ha ceduto tutto il suo patrimonio al marito.
Un accordo tra il fratellastro Richard e il padre dello sposo, oltre che la legge inglese, ha scambiato la dote di Antoinette con la protezione del futuro marito. Chi ha preso la decisione li obbliga di fatto a una sudditanza psicologica verso questo accordo che sancisce il bene per entrambi gli sposi. Loro non riescono, seppur restii, a rifiutarsi.
Cos’è questo se non un chiaro sintomo di società patriarcale, autoritaria e prevaricante? Rochester inoltre, fin da subito, la sente diversa da lui, estranea così come la natura intorno (un posto selvaggio. Non solo selvaggio, addirittura minaccioso. Quelle colline erano la per imprigionarti)
Anche i domestici, Christophine in primis, sono per lui incomprensibili e persone di cui non fidarsi. E tutto troppo diverso dal suo noto e questo lo mette in soggezione. Comunque ci prova ad amare la moglie e per un primo tempo questo accade e lo spirito selvaggio e notturno di Antoinette lo affascina e lo spinge a farla sua (Se io ho dimenticato la prudenza, lei ha dimenticato il silenzio e la freddezza). Purtroppo non riuscirà a trovare il coraggio per aprirsi veramente alle sue emozioni e ai suoi desideri (perché desiderio, odio, morte e vita erano terribilmente vicini nell’ombra. Meglio non sapere quanto fossero vicini. Non vicini: la stessa identica cosa), gli manca l’equilibrio psicologico necessario e ciò lo si deve a una educazione che lo ha voluto bambino invulnerabile (quanti anni avevo quando ho imparato a nascondere ciò che sentivo? Ero molto piccolo. Bisognava farlo e io ho sempre accettato questo atteggiamento). Dall’incontro tra la natura melodrammatica di Antoinette e la natura rigida e sospettosa di Rochester, ( per entrambi si è spento il bambino gioioso interiore), non può che nascere un conflitto anche di genere.
Così marito e moglie non riescono a evitare di ferirsi. Antoinette diventa Bertha. Il problema allora, come spiega la Miller, non è come eliminare il conflitto, ma come renderlo costruttivo. Come avrebbero potuto Antoinette e Rochester farlo? Dandosi la possibilità, un passo alla volta, di avvicinare i loro mondi differenti, i loro obbiettivi, ascoltandosi, imparando a fidarsi e comprendendo che l’altrui differenza, se accettata, diventa un valore che trasforma il Mare dei Sargassi in uno spazio di fusione, di incontro, di apertura e comunicazione. Ma loro non ci riescono: non hanno la maturità psicologica e un contesto sociale che li supporti in questo processo. Arriveranno a tradirsi, manipolarsi e tutto questo per non risentire l’antica sofferenza. Ancora appena prima del trasferimento in Inghilterra lui aspetta solo un cenno da lei, una richiesta di aiuto che lui sente la renderebbe per sempre sua. Antoinette però non è abituata ad essere protetta e può solo agire il suo coraggio istintivo e selvaggio e si chiude in sé stessa. Molto simbolico che li rincorra nella loro partenza un bambino piangente che chiede ciò che Antoinette non è in grado di chiedere: Aiuto.
Che vita è quella in cui i soldi sono il fine e non un mezzo?
Bertha isolata e imprigionata con Grace Poole. Anche qui sottolineo il grande talento della Rhys nel dare voce a questo personaggio minore in “Jane Eyre”. Che cosa porta un essere umano, in più donna, a farsi carceriere di un’altra donna? Soldi. Per averli Grace si imprigiona in un attico senza luce. Che vita è quella in cui i soldi sono il fine e non un mezzo? Cosa spinge un essere umano a non coltivare il proprio bambino interiore che è gioia, stupore, immaginazione e innocenza e purezza?
Antoinette ritrova nella angusta soffitta la sua parte istintiva (il rosso vestito) e questa la porta a sognare il suo destino e a comprendere il suo scopo: liberare sé stessa e con questa tutte le persone fragili e diverse e tutte le donne schiacciate da un patriarcato che le vuole solo succubi e obbedienti. Il fuoco come elemento distruttivo ma anche vivificante, riequilibrante e rigenerante. Bertha e Antoinette si incontrano tra le fiamme e pure Tia le sta spettando.
Conclusione: Jane e Antoinette, le due parti di una donna
Se potessero incontrarsi nel romanzo cosa si sarebbero dette? Come Jane, sempre così sensibile e comprensiva avrebbe parlato a Antoinette? A me piace pensarle unite e amiche in grado di dare all’altra quanto manca a sé stesse. Jane soffocò da piccola la parte ribelle e istintiva. Antoinette non sviluppò nella sua infanzia una capacità di relazionarsi agli altri.
La prospettiva archetipa inoltre, spiegata dalla Clarissa Pinkola Estès, ci aiuta a comprendere la natura duale del femminile, a conoscere le due potenti forze presenti in una stessa donna. La donna selvaggia, colei che riconosce profondamente sé stessa, è infatti una realtà duale: una esteriore che vive nel mondo di sopra (Jane Eyre nel nostro romanzo) e una creatura interiore (che vive in un mondo non facilmente visibile, “in un attico isolata”). L’essere esterno vive la luce del giorno ed è acculturata, delicata ed è facile da osservare e frequentare. La creatura interiore se arriva in superficie ci arriva partendo da molto lontano (attraversando grandi mari), apparendo e rapidamente scomparendo. Queste due parti che sono una sola donna si rincorrono, si completano, si supportano se ben educate a farlo. Se Jane e Antoinette si fossero conosciute chissà come si sarebbe conclusa la storia. Mi piace sognare che Bertha sarebbe ritornata a essere Antoinette, sarebbe tornata in Giamaica e grazie ai suoi averi e con l’aiuto di Jane e Rochester avrebbe fondato una scuola per i bambini poveri delle ex colonie.
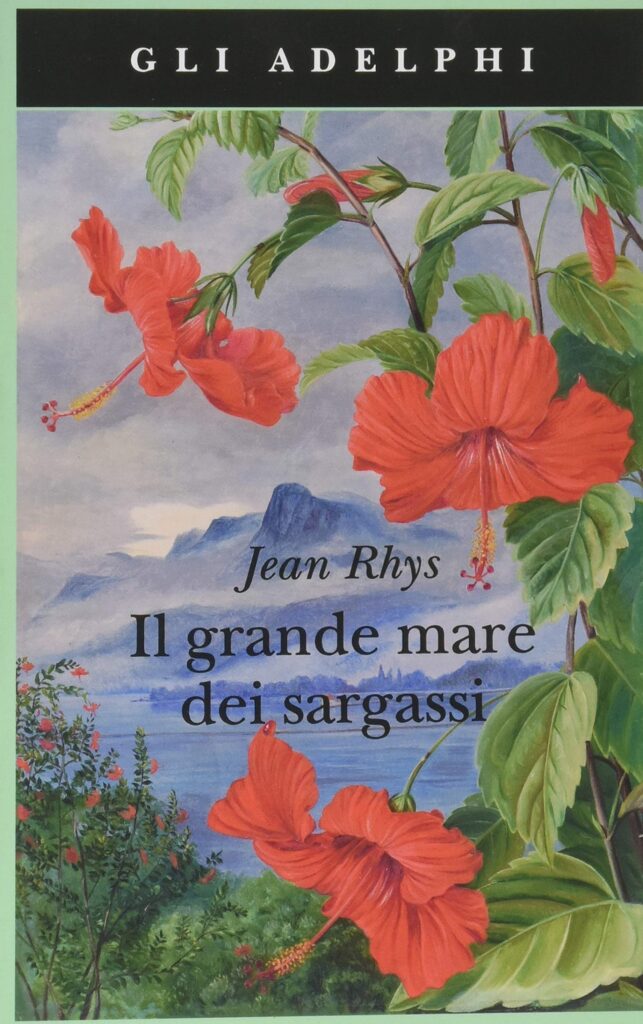
Il paper “Il gran mare dei Sargassi come spazio-simbolo del modello di dominio” è un elaborato nato per un Esame di Letteratura inglese (Università degli Studi di Udine – Master in Partnership e Sciamanesimo. Letterature, psicologia e società) e pubblicato successivamente anche sulla rivista BLUE GUM dell’Università di Barcellona.